 Loredana Lipperini, Michela Murgia, “L’ho uccisa perché l’amavo”/FALSO!, Laterza, 2013, euro 9
Loredana Lipperini, Michela Murgia, “L’ho uccisa perché l’amavo”/FALSO!, Laterza, 2013, euro 9
Si tratta di un pamphlet (come gli altri della collana Idola di Laterza), il cui obiettivo dichiarato è quello di smontare le opinioni più diffuse e correnti intorno al tema del femminicidio: “…bisogna imparare a parlare di femminicidio. Non solo i mezzi di comunicazione devono farlo. Dobbiamo farlo noi, e voi: perché tutti siamo ormai, ognuno nel proprio ambito, comunicatori. Dobbiamo imparare a riflettere per far passare il messaggio giusto. Non dobbiamo semplificare, per nessun motivo. Perché il rischio è quello che la semplificazione cannibalizzi e annienti quanto è stato fatto e il moltissimo che resta da fare.”
Parole sante per chi, come noi impegnate da anni nel lavoro di contrasto e di denuncia della violenza maschile contro le donne, si trova oggi di fronte al seguente paradosso: aver tanto fatto per far emergere dal silenzio e dal chiuso delle mura domestiche la violenza che lì dentro si nutre e si consuma contro le donne, e trovarci adesso di fronte a un chiacchiericcio mediatico sempre più esteso e perciò sempre più superficiale, che finisce con lo svuotare denunce, analisi, proposte che vengono dai luoghi dove di quella violenza ci si è fatte carico nel lavoro quotidiano di accoglienza a migliaia di donne.
Ed ecco un elenco dei luoghi comuni di cui le autrici cercano di dimostrare la falsità e l’inconsistenza: il più diffuso è certamente quello (a cui fanno ricorso quasi sempre i media italiani nei servizi di cronaca che sono ovviamente i più letti) di spiegare e leggere il femminicidio come un intreccio tra due elementi ‘irrazionali’ , amore e malattia, facendo passare l’idea che a causare la morte violenta delle donne sia di volta in volta l’amore di uomini malati o la malattia di uomini innamorati. “Chiamare relazione il dominio della vita della partner, chiamare gelosia l’ansia del controllo perso e soprattutto chiamare amore il rifiuto violento di accettare la libertà dell’altra persona è un’insopportabile manipolazione del significato reale delle parole.”
Altro luogo comune diffuso è che ‘l’omicidio non ha sesso’, che cioè nulla distingua il femminicidio da ogni altro omicidio: qui le autrici, dati e resoconti di fatti alla mano, non hanno difficoltà a smontare tale opinione, mostrando da un lato il fatto che la maggior parte dell’uccisione delle donne avviene in circostanze identiche, dall’altro che il femminicidio è assolutamente trasversale rispetto al censo e alla condizione economica e culturale di chi lo compie. Convincente anche il riferimento che le autrici fanno al ‘delitto d’onore’, superato legalmente nel 1981, ma ancora attivo nella mentalità e nell’approccio al problema.
Duro a morire e responsabile dell’atteggiamento che giustifica e minimizza, è anche lo stereotipo dell’uomo cacciatore e della donna seduttrice, che si nutre di famose e suggestive illustrazioni letterarie ed artistiche (dal Tasso della morte di Clorinda alla Lupa di G.Verga, alla Carmen, alle tante eroine di melodrammi e romanzi dell’800).
C’è, in fine, la posizione – presente anche in parte del mondo cattolico – di quelli che riconoscono la realtà del femminicidio ma che ritengono che il denominatore comune delle uccisioni di tante donne, non sia da ricercare nella cultura maschilista o nella diseguaglianza di potere tra i sessi, ma sia piuttosto “il frutto della ‘guerra ideologica’ aperta dal femminismo con le battaglie per i diritti e la parità sessuale…ad aprire il conflitto sono state le donne con rivendicazioni di parità che negano l’ordine naturale tra i sessi e cercano di minarne le fondamenta..dunque sta alle donne rimettere le cose a posto e far cessare le ostilità: basta dichiarare di essersi sbagliate e tornare alla casella iniziale.”
Da raccogliere per una discussione i rilievi critici che le autrici fanno nei confronti di quelle donne che si schierano contro il femminicidio in nome di una differenza intesa come naturale superiorità del sesso femminile: il riferimento è ad un articolo di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera, in cui afferma: “Il cambiamento passerà solo attraverso una consapevolezza superiore, che non è quella della parità dei diritti, bensì quella della diversità nel suo significato ‘più sacro’: è la donna a garantire la fine o la continuazione della specie.”
Infine, da sottolineare , in Appendice, l’intervento di Isoke Aikpitanyi dell’Ass. vittime ed ex-vittime della tratta che, denunciando che nel 2012 in Italia sono state uccise 10 ragazze nigeriane, osserva: “Che 100 e passa donne italiane possano essere uccise è osceno, ma se le italiane fossero uccise con la stessa frequenza con la quale sono uccise le nigeriane, le donne uccise in Italia sarebbero 4000!” Rileva inoltre che , nei servizi ed azioni contro la tratta è lasciato assai poco spazio alle ex-vittime che, come operatrici alla pari, avrebbero più efficacia per combattere quello sfruttamento che hanno vissuto sulla propria pelle.
G.P.
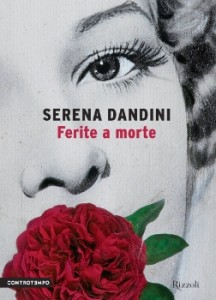 Serena Dandini, Ferite a morte, Controtempo, 2013, euro 15
Serena Dandini, Ferite a morte, Controtempo, 2013, euro 15
Forse prima che come libro, Ferite a morte, è conosciuto per lo spettacolo teatrale che la stessa Dandini ne ha tratto, chiamando sul palco figure diverse di donne, giornaliste, scrittrici, attrici, tutte vestite di nero, ciascuna a dare la propria voce alla storia che in prima persona ogni donna uccisa da un uomo, racconta di sé.
Il libro è appunto la raccolta di alcune di queste storie. Come dice la stessa Dandini : “Ho letto decine di storie vere e ho immaginato un paradiso popolato da queste donne e dalla loro energia vitale. Sono mogli, ex-mogli, sorelle, figlie, fidanzate, ex-fidanzate che non sono state ai patti, che sono uscite dal solco delle regole assegnate dalla società, e che hanno pagato con la vita questa disubbidienza. Così mi sono chiesta: ‘E se le vittime potessero parlare?’…Ferite a morte vuol dare voce a chi da viva ha parlato poco o è stata poco ascoltata, con la speranza di infondere coraggio a chi può ancora fare in tempo a salvarsi.”
Dunque si tratta di storie scritte dalle protagoniste da ‘dopo morte’, una sorta di ‘Spoon River’ al femminile, ogni storia molto breve, molto stringata, ridotta all’essenziale e rivolta al momento conclusivo, quello dell’uccisione. La prima comincia con una frase formidabile: “Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti.” In una delle ultime questa osservazione sconsolata: “Per le nostre leggi una rissa in un bar è molto più grave di ogni violenza dentro le mura di casa. Noi caschiamo in silenzio una dopo l’altra come le foglie i primi giorni d’autunno, poi veniamo spazzate via dal vento e nessuno si ricorda di noi.”
A differenza di parecchi libri usciti ultimamente in Italia sulle violenze alle donne, Ferite a morte, non ha lo sguardo rivolto solo al femminicidio in Italia ma si allarga ad abbracciare uno scenario globale a cui viene dedicata la seconda parte del libro. Qui l’autrice, in collaborazione con Maura Misiti, demografa e ricercatrice del CNR, raccoglie sotto forma di schede informative, la descrizione di pratiche molto diverse tra loro, ma che sono accomunate da una radice comune, l’avere come oggetto della violenza, portata fino alle forme estreme, la donna in quanto donna. Dalle uccisioni e stupri di donne in situazioni di guerra, alle donne bruciate a causa della dote in alcuni stati dell’Asia meridionale, dall’aborto di feti femmine e l’infanticidio delle bambine in Cina, India e Bangladesh alle uccisioni in massa di donne in Messico (pensiamo alla città messicana di Ciudad Juàrez, diventata simbolo del femminicidio oggi): sono solo alcune delle situazioni illustrate nelle schede, che nel linguaggio molto asciutto e diretto dei dati, danno un quadro impressionante della vastità e trasversalità della violenza che gli uomini esercitano sulle donne. Nella parte finale, molto critica verso la sordità e l’incapacità dei governi italiani ad affrontare il problema, sono segnalate invece politiche e misure adottate da altri Stati che rappresentano tentativi certo non riusciti, ma almeno più adeguati di fronte alla gravità della situazione. Molto aggiornato e completo l’insieme di informazioni raccolte sotto i titoli di: Strumenti e Fonti, molto utili sia per chi vuole agire contro violenza e femminicidio, sia per chi vuole studiare in modo approfondito questa realtà.
G.P.
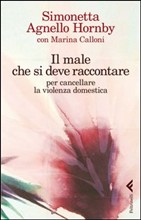 Simonetta Agnello Hornby, con Marina Calloni, Il male che si deve raccontare (per cancellare la violenza domestica), Feltrinelli, 2013, euro 9
Simonetta Agnello Hornby, con Marina Calloni, Il male che si deve raccontare (per cancellare la violenza domestica), Feltrinelli, 2013, euro 9
Simonetta Agnello Hornby, siciliana trasferitasi a Londra dove ha svolto la professione di avvocato e ha scritto nello stesso tempo diversi romanzi di successo (i più noti sono: La mennulara, Boccamurata, Il veleno dell’oleandro), collabora dal 2012 con la Global Foundation for
the Elimination of Domestic Violence. Nel testo che presentiamo, sono da subito evidenti le due facce dell’attività dell’autrice: quella di romanziera (di storie ambientate nella sua Sicilia, di cui sono protagoniste delle donne) e quella di professionista del diritto, impegnata prima in uno studio legale specializzato in diritto di famiglia e tutela dei minori che si dota poi di una divisione sulla violenza domestica, la prima in Inghilterra.
E’dall’esperienza fatta nei molti anni di attività dello studio legale che S. Agnello Hornby trae le sue conoscenze sui diversi aspetti della violenza domestica e raccoglie una grande quantità di storie di donne, dal momento in cui hanno incontrato nelle loro vite la violenza maschile alla conclusione, non sempre positiva, dei loro tentativi per uscirne. Alcune di queste storie sono raccontate con grande capacità narrativa, veri e propri ‘romanzi brevi’ nel corpo di un testo che alterna a queste pagine altre dedicate ad approfondire vari aspetti del problema ( gli attori della violenza, la violenza dei diversi e degli stranieri, il teatro della violenza, ecc.): con un risultato che riesce a catturare molto bene l’attenzione di chi legge, pur evitando la superficialità dei luoghi comuni e delle affermazioni scontate; un aspetto insolito, anche se rimane poco più di un accenno, è che dentro la violenza domestica l’A. colloca anche la violenza fatta da donne nei confronti di uomini (nel Regno Unito, il numero delle donne condannate per violenza domestica è in costante aumento, sebbene rappresenti solo il 7% del totale).
Di particolare interesse per una lettrice che vuole fare un confronto con la situazione italiana,
le notizie sia sulle norme in vigore in Inghilterra (ad es. quelle sull’ordine di protezione e sul ‘Legal Aid’, sorta di Gratuito Patrocinio) sia sul Piano nazionale d’azione del Regno Unito di cui è stata promotrice Patricia Scotland che ha ricoperto diversi incarichi ministeriali nei governi laburisti. Due le innovazioni principali introdotte dal piano: la creazione delle MARAC, ente statale che raccoglie diverse agenzie (servizi sociali, welfare, polizia,sanità, case per donne maltrattate, ecc.) che, in caso di rischio grave entrano in azione immediatamente e attivano la figura dell’IDVA (Independent Domestic Violence Advisor, cioè Consulente indipendente per la violenza domestica) che segue la donna nell’emergenza dell’episodio di violenza, ma anche per i mesi successivi nel percorso giudiziario, nella tutela dei figli, nell’assistenza sociale, ecc. Secondo l’autrice si devono al buon funzionamento di tale Piano sia la riduzione dei casi di femminicidio ( dai 49 del 2003 a Londra ai 5 nel 2010) sia l’aumento delle denunce.
Il confronto con la situazione italiana suggerisce alcune considerazioni: là dove funzionano i Centri antiviolenza gestiti da Ass. di donne (e questo purtroppo non accade dappertutto) sono le operatrici di accoglienza che assolvono le funzioni per cui in Inghilterra è stata introdotta la figura dell’IDVA , con modalità che mettono insieme professionalità e valenza politica del proprio intervento. In Italia, poi, nonostante gli sforzi di far nascere e funzionare reti e tavoli comunali e provinciali contro la violenza alle donne, le procedure di intervento sono ancora molto lente e farraginose.
Nella seconda parte del libro, dal titolo ‘Uccidono le donne’, Marina Calloni, docente di Filosofia politica e sociale all’Università di Milano/Bicocca, si occupa del quadro italiano, fornisce dati aggiornati su femminicidio e violenza domestica in Italia, confronta la serie dei dati a partire dal 2006 con i dati statistici a livello internazionale; inoltre fa un quadro abbastanza critico delle insufficienze di misure e leggi adottate in Italia per fronteggiare la violenza contro le donne. La stessa Calloni si è fatta promotrice dell’apertura di una Sezione Italiana della Global Foundation for Elimination of Domestic Violence.
G.P.
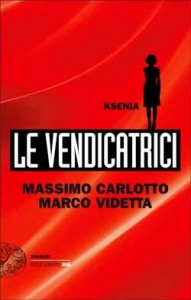 Massimo Carlotto e Marco Videtta, Ksenia. Le vendicatrici, Einaudi Stile libero, 2013, Euro 15
Massimo Carlotto e Marco Videtta, Ksenia. Le vendicatrici, Einaudi Stile libero, 2013, Euro 15
Premetto che non sono una lettrice di noir e che libri di Carlotto non ne avevo mai letti prima d’ora. Debbo dire che la vicenda mi ha tenuto in sospeso e tre ore di treno sono passate nella lettura senza che me ne accorgessi : alla fine del viaggio ero già a metà romanzo. I due autori, in questo romanzo che viene presentato come il primo di una serie che ha il titolo Le Vendicatrici, intrecciano tra loro le storie di alcune donne: Ksenia, Luz, Eva e Sara: le tinte forti di queste storie e degli ambienti in cui si snodano, non hanno nulla di forzato o esagerato rispetto a quelle realtà di violenza e sfruttamento di fronte a cui si trova ogni giorno chi è attivo in un Centro antiviolenza.
C’è in questo primo romanzo una protagonista, la giovane siberiana Ksenia, portata in Italia, a Roma, da un losco trafficante di donne, tramite tra la mafia siberiana e quella romana, che con raggiri e promesse ‘convince’ la ragazza a seguirlo per sposare un italiano che le farà fare una bella vita: giunta a destinazione, Ksenia si rende conto che il suo passaporto rimane in mano al trafficante che in questo modo la obbliga a sposare un vecchio vizioso e ripugnante che esercita nel suo quartiere l’attività di strozzino oltre a tenere le fila di svariati affari sporchi.
Praticamente ridotta ad oggetto di una sessualità pervertita, Ksenia dopo qualche tempo conosce Luz, giovane donna colombiana che fa la prostituta per vivere e, come si scoprirà più tardi, per mantenere sua figlia in un collegio di suore: tra le due ragazze nasce una forte attrazione che si trasforma presto in una relazione amorosa molto intensa. Altre due donne entrano per circostanze diverse, in relazione con loro: Eva, una quarantenne romana proprietaria di una profumeria, lasciata nei guai da un marito che ha preferito a lei la giovane commessa e il vizio del gioco da cui è dominato; ultima del gruppo la risoluta e crudele Sara, che svolge un ruolo molto importante nelle vicende che da un certo momento in poi stringeranno insieme queste quattro vite, ma che rimarrà fino alla fine avvolta in un mistero.
Raccontare oltre l’intreccio del romanzo non mi sembra un favore a chi legge; piuttosto farò alcune osservazioni: la prima riguarda il modo molto sommario e semplificato con cui sono tratteggiati i caratteri delle donne e le loro reazioni alle violenza, egoismi e superficialità con cui sono trattate dagli uomini (è da dire che del mondo maschile viene data una immagine veramente senza speranza, con poche eccezioni: il vecchio cubano ex-castrista che fa il badante ad una malata e, alla fine, il commissario di polizia che svolge le indagini) .
La seconda osservazione è positiva e riguarda la scelta fatta dagli autori di rovesciare il punto di vista a cui siamo abituate da tanta stampa e da tanti approcci al problema , che fa vedere nelle donne le vittime destinate e incapaci di reazioni di fronte a questo universo maschile di violenza e sopraffazione: qui l’elemento di forza che riesce a trasformare le loro vite, a renderle coscienti della situazione in cui si trovano e a dar loro la forza per rifiutarla, è la relazione che stringono tra loro, sono i legami di amore o amicizia e comunque di solidarietà che le fa capaci di superare la solitudine e la contrapposizione tra donne, una delle radici della loro e nostra debolezza. Il ricorso da parte loro alle armi della violenza e dell’inganno per ‘vendicarsi’ di questi uomini va inteso anche in senso realistico o, come sembra suggerito dalla citazione in exergo del romanzo, di una pagina tratta da ‘Dio è violent’ di Luisa Muraro, è in primo luogo portatore di una valenza simbolica?
G.P.
 Lilia Bicec, Miei cari figli, vi scrivo, 2013, I Coralli, eu.16
Lilia Bicec, Miei cari figli, vi scrivo, 2013, I Coralli, eu.16
“Se fossi una poetessa, dedicherei un’ode alle donne che sono andate a lavorare all’estero. Ma sono solo una madre, come tante, lontana da tutto ciò che per lei è più caro e prezioso.”
Così scrive la giornalista moldava Lilia Bicec, venuta in Italia a 35 anni a fare la badante e la colf, in exergo al suo libro recentemente pubblicato da Einaudi, in cui, attraverso lettere scritte per i suoi figli, racconta la sua esperienza di migrante , a partire dal fortunoso viaggio che la porta nel 2001 dalla Moldavia in Italia con una detenzione in Germania per documenti irregolari, attraverso il difficile inserimento nel lavoro di badante a Brescia, il dolore per la mancanza dei due figli lasciati piccoli e che si avviano durante gli anni della lontananza all’adolescenza, fino al divorzio dal marito rimasto in Moldavia e al faticoso ricongiungimento con i figli. Nemmeno il raggiungimento di questa meta così desiderata la mette al riparo dai duri colpi della sorte, su cui si conclude il suo racconto.
Di là dalle tappe della vicenda di Lilia, che si possono sovrapporre, cambiando solo qualche dettaglio,con le vite di tante donne migranti che vengono da noi per guadagnare con il lavoro di cura un miglioramento per sé e per i figli, mi hanno colpito alcuni aspetti del suo racconto che fanno di questo libro qualcosa di più di una testimonianza legata ad una vicenda personale. L’autrice è una donna curiosa, vuole conoscere la nuova realtà in cui si trova a vivere, vuole capirne la storia, vuole metterla a confronto con la realtà e la storia del suo paese. Come lei stessa afferma in una recente intervista al TG3*, quello che si rammarica di non poter dare ai figli non è solo la vicinanza e l’affetto, ma l’educazione. Ecco perchè nelle lettere ai figli, hanno spazio non tanto il racconto della durezza e della monotonia della sua vita quotidiana di badante e di colf, ma scorci di una storia (quella della 2° guerra mondiale e della Resistenza in Italia) che viene a conoscere dai racconti di un vecchio partigiano incontrato casualmente, oppure la rievocazione del trasferimento coatto della sua famiglia in Siberia sotto il regime sovietico, o ancora brani di storie di attraversamenti di frontiere e di vite di migranti irregolari che si intrecciano con la sua.
A testimoniare questa capacità di sguardo che sa mettere a frutto in un ambito più ampio la propria esperienza diretta, è il fatto che Lilia Bicec è stata organizzatrice ed è ora presidente a Brescia, dove risiede, di un’associazione di donne moldave “Moldbrixia”
*L’intervista si può scaricare dal sito RAI-TV, TG3 notte del 29/5/13
G.P.
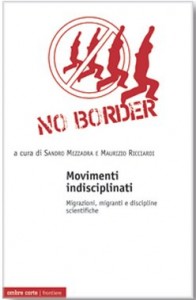 Roberta Ferrari, Donne, migrazioni, confini, in S.Mezzadra (a cura di), Movimenti indisciplinati, Ombre Corte, 2013, eu. 25, p. 29/49
Roberta Ferrari, Donne, migrazioni, confini, in S.Mezzadra (a cura di), Movimenti indisciplinati, Ombre Corte, 2013, eu. 25, p. 29/49
Il volume curato da Sandro Mezzadra ha come obiettivo principale quello di mettere in discussione l’idea di una pretesa ‘oggettività’ e ‘neutralità’ della scienza delle migrazioni. Primo presupposto dei contributi del volume: le migrazioni contemporanee sono un perfetto esempio di ciò che viene definito “fatto sociale totale”. Esse investono cioè l’insieme delle dimensioni costitutive di una società, delle società di partenza come di quelle di arrivo passando attraverso quelle che le pratiche ‘transnazionali’ dei migranti pongono in relazione. Altro presupposto è l’individuazione del carattere antisistemico delle migrazioni che si manifesta anche se l’intenzione dei loro protagonisti non lo è: il carattere totale del fatto sociale ‘migrazioni’ si mostra nell’impossibilità di una sintesi degli elementi che lo compongono, nel momento in cui i suoi movimenti attraversano in continuazione (essendone a loro volta attraversati) tanto la linea del colore, quanto quella di genere quanto infine quella di classe.
Il saggio di R.Ferrari non si ferma ad una considerazione appiattente in senso statistico o solo descrittiva della migrazione femminile oggi, ma ha una pretesa più alta: “Al centro dell’analisi sta pertanto la questione: cosa dice la mobilità delle donne sul posto delle donne nel mondo? Guardare contemporaneamente al femminismo e ai movimenti globali per capire come reciprocamente si interrogano vuol dire, innanzitutto, restituire, da un lato, al femminismo l’autorità di un discorso sulle trasformazioni del mondo e, dall’altro, alle migranti, (…) i loro corpi di donne.”
Se i numeri ci dicono che già nel 2010 le donne erano il 51,6% di tutta la popolazione migrante su scala globale, ancora più significativo è il consistente numero di donne che migrano sole, di donne cioè che si muovono per lavorare, per mantenere le famiglie nei paesi di provenienza, intercettando la richiesta del lavoro di cura in costante crescita per motivi diversi (tra cui l’aumentata prosperità dei paesi ad economia emergente che richiede sempre più lavoro riproduttivo o la scarsa efficienza del Welfare pubblico, come ad es. in Italia).
Interessante è anche la quota di donne migranti laureate (il 17.6 % contro il 13.1% di uomini), che mette in luce il processo in atto di svalutazione e proletarizzazione entro cui queste migranti si trovano, ma fa vedere anche la ricerca di mobilità sociale e innalzamento del tenore di vita come molla per la partenza. Cresce anche la cosiddetta migrazione “circolare” o temporanea, che permette alle migranti di tornare dai figli temporaneamente affidati ad altre donne nei paesi di provenienza e ‘passare’ per un periodo definito, il lavoro ad altre donne ancora, in un circolo ‘virtuoso’ che peraltro fa dello spazio domestico l’unico luogo di vita. L’altra faccia dello spazio domestico è rappresentato poi dalle migranti coinvolte, in diversi modi, dal traffico del sesso.
I dati italiani riflettono in linea di massima il trend internazionale. Oltre a insistere sullo sfruttamento duplice sul mercato del lavoro, come donne e come migranti (livelli salariali, orari di lavoro estenuanti, isolamento, abusi, ecc.) e a sottolineare il carattere penalizzante della maternità che riguarda non solo il lavoro domestico e di cura, ma anche il lavoro in fabbrica o nelle cooperative, l’autrice mostra poi come la istituzionalizzazione delle badanti e della’migrante’ come figura precaria e domestica diventa centrale nell’organizzazione contemporanea del lavoro e rappresenta il nuovo volto del welfare dove i servizi sono acquistati sul mercato e non vengono più considerati un prolungamento della cittadinanza.
Il meccanismo del congiungimento familiare,poi, che lega il permesso di soggiorno delle donne a quello degli uomini, mostra come il governo delle migrazioni delle donne avvenga ancora sul piano di una cittadinanza patriarcale.
“Il welfare rappresenta allora il terreno sul quale si riorganizza la (non)cittadinanza delle donne. La salarizzazione del lavoro riproduttivo, che non elimina il lavoro non pagato ancora assegnato primariamente alle donne, rappresenta un processo di “addomesticamento” del lavoro diretto alla cristallizzazione della divisione sessuale del lavoro su scala transnazionale e allo stesso tempo alla privatizzazione del luogo di lavoro,vale a dire alla spoliticizzazione del conflitto lavorativo.”
Se il dibattito italiano sulla migrazione femminile è stato dominato negli anni ’90 dal tema dell’integrazione e si è trascurata la soggettività messa in campo dalle migranti, in seguito, grazie soprattutto al fecondo apporto del dibattito teorico internazionale, sono emersi temi e punti di vista più critici e capaci di combinare e intrecciare tra loro elementi diversi come razza, sesso, classe, nazionalità, orientamento sessuale (i riferimenti sono a: Mapping the Margins di Krenshaw, Servant of Globalisation di Parrenas, Donne Globali di Ehrenreich e Hochschild 2004). Così si è giunti ad una immagine diversa della donna migrante. “Queste donne migrano perché rifiutano di lavorare per poi consegnare il salario a padri e mariti, e quando continuano a farlo attraverso le rimesse, lo fanno invertendo in buona parte gli schemi familiari tradizionali (…) Queste donne migrano anche per ambizione, immaginando un percorso autonomo per la propria vita.”
La ‘catena globale della cura’ comporta anche proliferazione di gerarchie interne alle relazioni tra donne: di fronte ad esse il dibattito femminista in Italia ha accentuato l’elemento conflittuale da un lato (il rapporto serve/padrone), ha tentato dall’altro (ad es. Muraro, Il valore delle colf) di vedere piuttosto la forza della complicità tra le donne stesse. Al contrario può succedere che ad essere fatto salvo dalla conflittualità di questi rapporti sia esclusivamente il ruolo maschile, libero dalle incombenze del lavoro riproduttivo. Per quel che riguarda le donne, invece, il ‘destino domestico’ continua ad intrappolare entrambe le figure, anche se in modo diverso, obbligandole nello schema serva-padrona.
E’ sul terreno della cittadinanza che si gioca la possibilità di uno scarto rispetto allo schema sopra analizzato, non però dando credito ad un allargamento della cittadinanza ad includere pienamente le donne, ma piuttosto lavorando sul carattere paradossale della cittadinanza sperimentata dalle migranti:
“Le migranti spingono all’estremo il percorso delle donne oltre la cittadinanza, perché agendo da non cittadine non invocano la sola cittadinanza, ma incrinano le sue regole e mettono in tensione le sue norme. Le donne stanno al centro di questa crepa e pongono il problema critico della cittadinanza, riportando al suo interno la qu4estione del potere.”
Questi, in sintesi, i punti più interessanti di questo saggio molto denso di problemi e riferimenti tutti molto significativi, di cui è consigliabile la lettura e da cui potrebbe partire una discussione tra chi si sente in modi diversi e con posizionamenti diversi implicata e chiamata in causa dalla questione della migrazione. L’autrice fa riferimento al sito www.Migranda.org come luogo di elaborazione ed intervento sui temi della migrazione femminile.
G.P.
